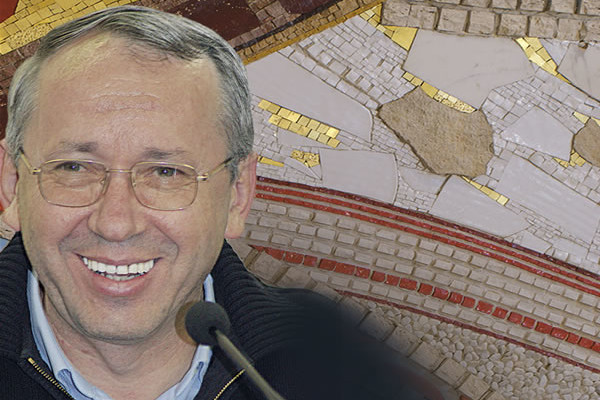Artista di grande sensibilità, teologo rigoroso, padre Marko Ivan Rupnik, gesuita, è direttore del Pontificio Istituto Orientale – Centro Aletti di Roma e dell’Atelier dell’arte spirituale dello stesso Centro, con il quale ha realizzato apprezzati mosaici in Italia e all’estero: fra gli altri, nella cappella Redemptoris Mater del Palazzo apostolico vaticano, sulla facciata della chiesa del Rosario a Lourdes, nella rampa e nella cripta della nuova chiesa di san Pio da Pietrelcina a S. Giovanni Rotondo, nel nuovo santuario di Fatima e in quello dedicato al beato Giovanni Paolo II a Cracovia.
Lo incontriamo mentre disegna, per chiedergli del suo rapporto con la Terra Santa, dove si è recato due anni fa insieme all’équipe del Centro Aletti. «È stata la mia prima volta», afferma. «Non ho mai desiderato andarci: ho sempre pensato che mi sarebbe piaciuto visitare quei luoghi dopo la morte, accompagnato dal Signore».
Un desiderio decisamente particolare…
Ricordo che da bambino, soprattutto a Natale, cercavo di immaginare i luoghi nei quali si svolse la vita di Gesù. Allora papà, che era un fine pedagogo, mi ripeteva sempre che è importante sforzarsi di comprendere cosa è accaduto a Betlemme, ma non meno importante è capire come questa nascita accade qui, nella nostra casa, nel nostro villaggio. Poi, da giovane gesuita, durante il noviziato, ebbi modo di riflettere sulle parole di Origene, secondo il quale Cristo nasce diverse volte, una a Betlemme, le altre nei nostri cuori, e tutte sono parimenti decisive. La verità è che la Palestina costituisce il passaggio affinché ciascuno di noi, in ogni luogo, possa vivere questo mistero dell’umanità che accoglie la divinità. Così, pian piano, è maturato quel desiderio di visitare la Terra Santa solo dopo la morte, accompagnato dal Signore.
Come mai allora è accaduto che si sia recato in Terra Santa?
La mia équipe era desiderosa di partecipare ad un pellegrinaggio e dunque accettai di unirmi a loro perché pensai fosse molto bello andare tutti insieme: ciò che si conosce nella comunione rimane, non si scorda, è una conoscenza diversa da quella che si raggiunge da soli.
Nel viaggio, ad accompagnarci, vi fu una guida straordinaria, don Giacomo Morandi: con lui visitammo e sostammo in quei luoghi che ci rendono contemporanei a Gesù: seguendo questo criterio, vivemmo un’esperienza molto intensa. È un po’ come quando accompagno gli studenti a visitare San Pietro: entrando nella piazza, dico sempre loro di osservare molto bene l’obelisco perché è lì che ci si incontra con Pietro: quello è l’obelisco che vide l’apostolo e lo vide, molto probabilmente, anche negli ultimi istanti della sua vita. È questo l’oggetto che ci rende contemporanei a lui.
Come descriverebbe l’esperienza spirituale vissuta durante il pellegrinaggio?
Potrei dire che, per me e i miei collaboratori, quel pellegrinaggio ha rappresentato soprattutto una potente esperienza ecclesiale, comunionale. Trascorremmo dieci giorni dando sempre la precedenza al Signore, sperimentando, concretamente, come Dio ha vissuto da uomo e come l’umanità si fa accogliente e si trasfigura in questa nuova esistenza relazionale: fu una tensione spirituale che consolidò e vivificò in noi la dimensione ecclesiale, ossia il percepirsi corpo di Cristo. E questa è una dimensione fondamentale che qualifica un’esistenza autenticamente cristiana.
È rimasto colpito dalle opere d’arte viste in Terra Santa?
Direi di no. Delle epoche nelle quali l’arte sapeva cogliere la presenza del mistero, ossia il primo bizantino e il primo romanico, sono rimaste ben poche testimonianze, mentre ve ne sono in gran numero delle epoche successive, ma sono per lo più scenografiche e decorative: poco interessanti, per me. Durante il pellegrinaggio prestai invece molta attenzione ad alcuni luoghi, agli alberi, alle nuvole, al vento, alla luce…
Si può dire che è stato attratto meno dalla dimensione artistica e più da quella estetica…
Sicuramente, in quanto l’estetica tratta della bellezza ed essa è l’amore realizzato, il quale non è altro che la verità che si rivela come amore. E dove si è rivelata la verità come amore se non proprio in Terra Santa? È proprio questo che cercai di cogliere durante quel pellegrinaggio, camminando e osservando, in silenzio.
A suo giudizio, la cultura occidentale è sensibile, anche in chiave educativa, alla dimensione artistica ed estetica?
Purtroppo no e sono persuaso che andrà sempre peggio perché, ormai da secoli, domina una cultura scientifica, empirica, matematica, che ha smarrito il senso del mistero dell’essere umano. È sufficiente considerare il ruolo che hanno le arti per la conoscenza: nessuno. Se oggi una persona affermasse che la poesia e le arti figurative sono vie regali alla conoscenza susciterebbe un sorriso di compatimento.
Il simbolo è stato ucciso secoli fa ed è vero che oggi lo abbiamo riscoperto, ma solo a livello linguistico, semantico: il simbolo è stato ridotto a qualcosa che ne significa un’altra, mentre esso è presenza, è comunicazione di una presenza, che genera comunione. La Terra santa è un luogo eminentemente simbolico, nel senso vero, teologico: vai lì, vedi un albero ed esso ti unisce a un evento e a una Persona: ciò è straordinario.
Avrebbe grande valore educativo, per costruire una cultura autenticamente umanistica e quindi relazionale, riscoprire i luoghi della cristianità, anche in Europa: sarebbe un progetto interessantissimo, che non dovrebbe però avere una connotazione ideologica, ma spirituale, culturale, estetica nel senso di cui dicevamo poc’anzi.
Non ha mai avuto desiderio di realizzare un mosaico in una delle località visitate?
No, quando sono in giro per il mondo non ho mai questo desiderio perché da anni vivo la mia vocazione come risposta a una chiamata: se mi chiama la Chiesa, allora rispondo sapendo che la via è giusta. Però, lo ammetto, in alcuni edifici sacri visitati mi sono ritrovato a pensare che forse gli artisti avrebbero potuto operare diversamente, con maggiore semplicità, forza, densità. Pensiamo al primo bizantino e al primo romanico: quell’arte aveva un linguaggio essenziale, semplice, povero quasi, capace di accogliere l’azione di Dio. Quando le forme sono elaborate, ricercate, perfette, non c’è più nulla da aggiungere: in esse è presente solo l’uomo, che ha fatto tutto. E non c’è più posto per Dio.
Quali ricordi conserva di Gerusalemme?
I momenti vissuti sul Getsemani furono così intensi che non li scorderò mai, sono dentro di me con il sapore e il gusto che mi diedero in questi istanti. Rammento vividamente come mi apparve la città da quell’altura: è un’angolatura geografica, ma soprattutto teologica: dal luogo in cui Dio si è consegnato nelle mani degli uomini appare la spianata del tempio e lì «vedi» il cammino e il travaglio della storia per giungere a un rapporto divino-umano davvero libero e di amore: la divina umanità di Cristo ha inaugurato una nuova era, sono finiti un culto, un sacrificio, una liturgia: si è compiuto il passaggio dalla religione alla fede, a un Dio che ha un volto. Lo ripeto: quella che si ha dal Getsemani è un’angolatura potente, perché poi guardi verso il deserto di Giuda, verso quella strada che da Gerusalemme scende a Gerico, e capisci il racconto di Gesù, capisci perché il sacerdote e il levita, osservando i loro precetti religiosi, non si fermarono a soccorrere il malcapitato, mentre un uomo, un samaritano, seppe vedere e intervenire. Il cristianesimo è religione della cura e della misericordia.
Ricordo molto bene anche la discesa percorsa da Pietro, dove l’apostolo sperimentò sino alle lacrime tutta la fragilità umana che si appoggia a se stessa, confidando solo sulle proprie capacità, sul proprio io. L’apostolo vide crollare la sua presunzione, le sue promesse andarono in frantumi e si scoprì «nudo»: fu in quel momento che incontrò lo sguardo di Cristo e la sua misericordia.
L’esperienza di Pietro è esemplare: appare sempre difficile per l’essere umano accettare di farsi salvare da Dio.
Più passano gli anni più sento la verità della Sacra Scrittura: nel capitolo 3 della Genesi vi è l’inizio di tutto: l’uomo ha rinunciato ad essere sacerdote e ha scelto di essere consumatore: invece di rendere sacrificio di grazie e di lodare il Creatore per ciò che ha ricevuto, riconoscendone in questo modo l’origine e lo scopo, ha deciso di prendere, di afferrare predatoriamente. Aprire la mano per ricevere è difficilissimo. L’accoglienza è senza dubbio l’impegno più faticoso che l’umanità affronta, in ogni epoca. Tanto è vero che oggi si parla meno di accoglienza è più spesso di tolleranza, che è ben altra cosa.
In Medio Oriente, e non solo in quella regione del mondo, i cristiani spesso vivono nella sofferenza, vittime di violenze e persecuzioni. Non pensa che i cristiani d’Occidente dovrebbero nutrire verso di loro maggior riconoscenza e concreto affetto?
Certamente. Purtroppo, i sentimenti di affetto e riconoscenza verso questi nostri fratelli sono piuttosto rari. Ho l’impressione che prevalga l’indifferenza o una empatia alquanto superficiale. Anni fa, quando il comunismo era saldo nei Paesi dell’Est e noi venivamo in Europa a raccontare la nostra difficile esperienza, non incontravamo, generalmente, un’autentica comprensione: molti erano dispiaciuti per la nostra mancanza di libertà, ma non elaboravano una lettura teologica degli avvenimenti: in altri termini, non arrivavano a comprendere che la salvezza passa attraverso la croce, sempre. Solo chi porta veramente la croce è in grado di capire chi ne porta una più pesante. Chi si aspetta una salvezza miracolosa, facile, a buon mercato, non potrà mai capire davvero le sofferenze che vivono i nostri fratelli perseguitati.