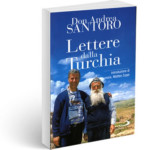Gustav Meyrink, l’enigmatico scrittore viennese-praghese autore del Golem sentenziava: «Quando arriva la conoscenza, arriva anche la memoria, passo dopo passo. Conoscenza e memoria sono una sola e medesima cosa».
Un chilo di cioccolato costituisce appunto un contributo minuscolo ma prezioso alla conoscenza di un «passato che non passa», realizzato non mediante gli strumenti della storiografia bensì con quelli dell’autobiografia, cioè della memoria personale. L’autrice, Chava Kohavi Pines, allorché nacque a Vienna nel 1927 si chiamava Eva Hirsch. Cresciuta in una famiglia della media borghesia ebraica assistette inerme alle pesanti angherie che la grande comunità ebraica di Vienna dovette subire dopo che Hitler mise in atto l’Anschluss, l’annessione dell’Austria al Terzo Reich nazista. Nel 1942 Eva, nel pieno dell’adolescenza, venne deportata con la madre nel ghetto di Theresienstadt, in Boemia, e di lì, l’anno successivo, ad Auschwitz e infine in un campo di lavoro vicino a Breslavia. A guerra terminata, nella primavera del 1945 la ragazza si ritrovò sola al mondo: la mamma era stata eliminata quasi subito dopo essere entrata nell’inferno di Auschwitz. Animata dal comprensibile desiderio di ritornare in patria, nell’amata Vienna, Eva non tardò a sperimentare sulla sua pelle la delusione di un’impossibile ricollocazione nella città-matrigna in cui aveva vissuto i suoi anni verdi. E dopo un breve periodo trascorso a Praga, nel 1946 scommise di cercarsi una patria più genuina e autentica in Palestina. E vinse la scommessa andando a vivere in un kibbutz nel nord del Negev, dove ritrovò se stessa assumendo il nome con il quale firmerà questo suo libro.
Affinché Chava decidesse di narrare la dolorosa tragedia della sua odissea giovanile tra l’Austria, la Boemia e la Polonia, le occorreva lasciar passare ben quattro decenni: una distanza dagli eventi che accomuna – con poche eccezioni – molti di coloro che, sopravvivendo all’orrore, ci hanno trasmesso le memorie della Shoah.
Perché conservare e trasmettere la memoria? A sette decenni di distanza dalla Shoah, che cosa possono ancora insegnare quei misfatti agli uomini d’oggi?
Innanzitutto non possiamo dimenticare che la Shoah ha inghiottito sei milioni di persone: approssimativamente la metà degli ebrei europei, ossìa circa un terzo degli ebrei del mondo, fra i quali un milione e mezzo di bambini. Ma soprattutto, nella Shoah è andata distrutta una civiltà, quella degli ebrei dell’Europa centro-orientale. Dell’antico scenario fisico entro il quale si mossero e fiorirono numerose comunità estremamente vitali e creative, oggi non rimangono che i muri delle sinagoghe, i cimiteri, i libri, gli oggetti rituali e d’uso quotidiano, le carte: documenti di una storia durata poco meno d’un millennio. Pagine della storia degli ebrei, certamente, ma anche, a pieno titolo, della storia d’Europa e – vorrei aggiungere – della storia dell’intera umanità.
Come ha scritto il compianto Yosef Hayim Yerushalmi, docente alla Columbia University di New York, la necessità di ricordare è divenuta più urgente da quando hanno alzato la voce «coloro che fanno a brandelli i documenti, gli assassini della memoria e i revisori delle enciclopedie, i cospiratori del silenzio, coloro che, come nella bellissima immagine di Kundera, possono cancellare un uomo da una fotografia in modo che ne rimanga solo il cappello». Quella che ci risulta intollerabile è l’idea che persino i crimini più atroci possano cadere nell’oblio. In sostanza, il bisogno di ricordare riguarda il male.
Certo, la Shoah non rappresenta l’unico inferno cui il Ventesimo secolo abbia dato luogo. Ma il genocidio ebraico, compiutosi nel cuore stesso di quella cultura europea e cristiana che era stata la culla della modernità, è e continuerà a essere la matrice fondamentale per la comprensione del nostro tempo storico. Evento rivelatore del contrasto tra il potere spaventoso degli uomini e la loro inettitudine a crescere sul terreno della civiltà, si porrà per sempre quale paradigma e testimonianza della millenaria follia del mondo.
Da più parti si sostiene che, in quanto male assoluto, la Shoah sia qualcosa di indicibile, di irrappresentabile. Si tratta, in questo caso, di un’opinione che non condivido. Ritengo infatti che anche il lavoro di coloro che fanno storiografia avrebbe uno spessore molto inferiore se non potesse fare riferimento proprio alle narrazioni dei testimoni diretti, dei deportati, dei sopravvissuti. Ai fini della conservazione e trasmissione della memoria, il racconto individuale offre spunti e risorse di una vitalità unica, insostituibile: basti pensare alle narrazioni e alle riflessioni preziosissime di un grande testimone quale fu Primo Levi.
Nel novero delle testimonianze dirette, Un chilo di cioccolato trova una sua dignitosissima collocazione. Articolata in una quindicina di sapidi flash autobiografici, la storia raccontata da Chava colpisce per lo stile narrativo: asciutto, senza divagazioni ideologiche, senza ombra di retorica.
Chava Kohavi Pines
Un chilo di cioccolato
Diario di una ragazza ebrea ad Auschwitz
Edizioni Terra Santa, Milano 2017
pp. 104 – 14,00 euro