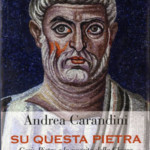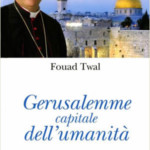Leggere questo libro della storica Anna Foa significa ripercorrere la genesi e lo sviluppo di un fenomeno tutto italiano, quello appunto dei quartieri chiusi da mura e portoni in cui gli ebrei finirono segregati dal XVI secolo fino all’Emancipazione dando origine alla cosiddetta «età dei ghetti». Un fenomeno, argomenta la Foa, strettamente legato a come la Chiesa cattolica percepiva il rapporto con gli ebrei.
Il ghetto di Roma non esiste più, benché le mura a ridosso del Portico d’Ottavia rechino i segni della spinta alle conversioni patite dagli ebrei. A Venezia, Torino, Ferrara e Firenze i quartieri dove erano stati confinati gli ebrei sono ancora ben visibili, mentre nel sud Italia solo negli ultimi anni si è scavato all’interno di un’assenza, fino a far riemergere i segni della frattura che c’è stata. Luoghi, storie e percorsi dell’Italia ebraica raccontate in un’agile guida da una delle massime esperte dell’esperienza ebraica in Occidente.
Il fatto è che Andare per ghetti e giudecche, come recita il titolo di questo bel libro di Anna Foa che offre non pochi spunti di riflessione nell’imminente Giornata europea della cultura ebraica, significa ripercorrere la genesi e lo sviluppo di un fenomeno tutto italiano, quello appunto dei quartieri chiusi da mura e portoni in cui gli ebrei finirono segregati dal XVI secolo fino all’Emancipazione (intorno a metà Ottocento – ndr) dando origine alla cosiddetta «età dei ghetti».
Un fenomeno, argomenta la storica, strettamente legato a come la Chiesa percepiva il rapporto con gli ebrei. Perché se era stata la Chiesa cattolica nei secoli precedenti a sancire la diversità ed in un certo senso la «necessità teologica» dell’esistenza degli ebrei, e fin dall’alto Medio Evo esistevano le giudecche, ovvero i quartieri aperti dove ebrei e cristiani vivevano insieme senza limitazioni, a partire dal Cinquecento fu proprio la Chiesa ad imporre l’idea di creare spazi deputati all’attesa della conversione e al controllo dei «diversi» per antonomasia, e non solo alla loro separazione. Proprio il ghetto di Roma – voluto da Paolo IV nel 1555 e nel quale le pressioni, la chiusura, l’arretratezza della comunità rimasero più forti che nel resto d’Italia fino al 1870 – fu espressione del tentativo di mostrare come l’unica via d’uscita per gli ebrei fosse la conversione, in un clima di uniformità culturale e di omologazione del mondo esterno.
Non così avvenne a Venezia, dove nel 1516 la necessità di creare una regolare comunità di prestatori di denaro e di tenere sotto stretto controllo le attività degli ebrei aveva portato alla creazione del primo ghetto della storia (gheto deriva dalla pronuncia tedesca di geto, per via delle fonderie esistenti sull’isola di Cannaregio), ovvero «il luogo dove abitano gli ebrei» come ebbe a spiegare l’avventuriero levantino David Reubenì di passaggio nella città lagunare nel 1524. Ma l’ampio Campo del Ghetto nuovo di Venezia, oggi méta di un flusso inarrestabile di turisti di tutto il mondo, grazie all’arrivo di mercanti levantini, portoghesi e sefarditi accanto all’originario gruppo di banchieri askenaziti, si trasformò nel centro di una comunità la cui importanza per la vita economica e culturale di Venezia andava ben al di là del ruolo esercitato dai prestatori e dai loro banchi, come testimoniano la bellezza delle sue cinque sinagoghe (una per ogni «nazione») ed il portoncino verde del bet-ha-midrash di Leone da Modena, uno dei più noti, ammirati ed eclettici fra i rabbini del Seicento.
Anna Foa spiega come altrettanto ricca e vivace fu la vita culturale a Mantova, pur in mezzo ad asperrime persecuzioni. Punizioni che non risparmiarono Ancona, con 25 roghi di «marrani» (ebrei portoghesi forzatamente convertiti), sempre a causa dell’ascesa al soglio pontificio di Paolo IV nel 1555. E mentre nel 1553 avveniva a Roma il primo rogo del Talmud, in quegli anni il poeta e storico Samuel Usque poteva definire la corte degli Este a Ferrara «il porto placido e sicuro preparato per Israele dalla infinita misericordia di Dio».
E ancora: i banchi di Bologna come simbolo del ruolo del prestito ebraico nella relazione fra la città e gli ebrei, la sinagoga di Livorno, la piccola e colta comunità di Pitigliano. La mappatura di ghetti e giudecche ricostruita dalla Foa riserva non poche sorprese sulle diverse caratteristiche ed esperienze che le comunità ebraiche hanno vissuto nel nostro Paese. La studiosa narra, ad esempio, come nel Sud Italia l’ebraismo fosse entrato in crisi per le persecuzioni e la pressione proselitistica della Chiesa molto prima del 1492. Al punto che solo negli ultimi anni l’interesse degli archeologi ha portato alla riemersione delle tracce di centinaia di insediamenti ebraici sparsi in tutto il Mezzogiorno. In Piemonte non è un caso che le sinagoghe monumentali di Vercelli e Torino (dove la Mole Antonelliana oggi simbolo della città e sede del Museo del Cinema nacque inizialmente come progetto del tempio della comunità ebraica) siano una chiara espressione dell’avvenuta emancipazione, mentre quella di Casale Monferrato (una delle più sinagoghe più belle e meglio conservate d’Italia) si trova all’interno di un palazzo dalle mura alte e austere, quasi a volersi camuffare nelle stradine del centro storico.
Il libro è una lettura godibilissima e di grande interesse per chiunque voglia conoscere, attraverso le tracce architettoniche e urbanistiche disseminate in molte delle nostre città, la storia della presenza degli ebrei in Italia.
Anna Foa
Andare per ghetti e giudecche
il Mulino, Bologna 2014
pp. 122 – 12,00 euro